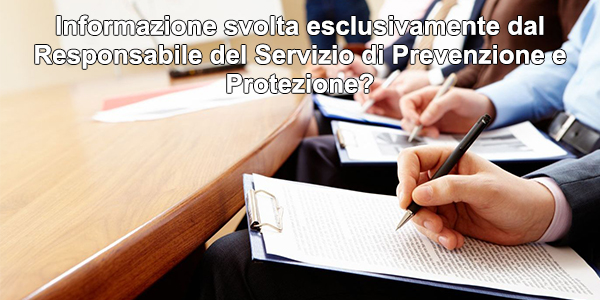di Silvia NUTINI e Alessia BOLDRINI
Il dipendente addetto al controllo dell’accesso al porto agiva in giudizio ex art. 2087 c.c. avverso il licenziamento, avvenuto per superamento del periodo massimo di comporto. Egli era rimasto infortunato e aveva subito una lunga serie di interventi a seguito di una caduta avvenuta mentre si recava alla toilette che distava oltre 300 metri dalla sua postazione. Su tali premesse il lavoratore aveva addotto l’illegittimità del proprio licenziamento, allegando la violazione del D.P.R. n. 303/1956 art. 39, che impone che i gabinetti debbano trovarsi in prossimità del posto di lavoro; nonché del più generale obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza previsto dalla direttiva 89/391/CE.
Il tribunale in primo grado rigettava il ricorso del lavoratore; la Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dal medesimo, motivando con l’insufficienza delle allegazioni del dipendente che non aveva sufficientemente dimostrato il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la nocività dell’ambiente di lavoro.
Innanzitutto era emerso che nel tragitto postazione-gabinetti non vi erano insidie tali da costituire un rischio per l’incolumità delle persone, contrariamente all’asserita incompletezza del documento di valutazione dei rischi. Inoltre rilevava che i più vicini bagni rispetto alla posizione del lavoratore non erano quelli posti a una distanza di ben 300 metri, bensì altri, aperti al pubblico, posizionati a soli 60 metri e perciò in regola con la normativa preventiva supposta violata.
Faceva ricorso in Cassazione il lavoratore, il quale non condivideva la motivazione data dal giudice di secondo grado e perciò lamentava un vizio motivazionale con riguardo alla prova dell’infortunio; assumeva infatti di avere dato sufficiente prova del rapporto di lavoro subordinato, del danno riportato e del legame causale tra rapporto lavorativo e danno, tant’è che l’istituto previdenziale INAIL aveva aperto il sinistro relativo. La Corte ha richiamato l’insegnamento univoco seguito da numerose sentenze, secondo cui incombe sul lavoratore che si duole per avere subito un danno a causa dell’attività lavorativa svolta, l’onere di provare non solo l’esistenza di tale danno occasionatosi sul luogo di lavoro, ma anche la cosiddetta “nocività” del luogo di lavoro. Di contro, è onere del datore di lavoro dare prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Infatti, ragiona la Corte, “Allegare e provare la nocività dell’ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell’obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca, deve scaturire l’indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 c.c.” Qui fa richiamo ad una giurisprudenza consolidata della stessa Corte di legittimità, per cui l’allegazione del creditore di sicurezza (alias lavoratore infortunato) non può attenere ad un inadempimento qualunque, ma ad un inadempimento qualificato nel senso che il comportamento del datore deve essere astrattamente in grado di causare il danno. Competerà invece al debitore (alias datore) dimostrare l’adempimento o la mancanza di nesso causale. Pertanto la Cassazione civile sez. lavoro, con sentenza n. 12241 del 12 giugno 2015, rigettava il ricorso.
Safety Focus – Anno II – Numero 10 – 4 Luglio 2015